

Il “clima castagnoso” di Castello di Cireglio
di Maurizio Ferrari
Policarpo Petrocchi lo definiva così e fu il primo ad utilizzare questo termine nel suo dizionario. Parrebbe voler dire “popolato di piante di castagno”; ma questa è un'interpretazione superficiale. In realtà l'aria castagnosa coinvolge tutti e cinque i sensi naturali: un microcosmo in cui presente e passato si fondono, un'identità, una natura ed un destino

La nostra lingua si è davvero impoverita. Ce lo conferma il vecchio Dizionario del Petrocchi
di Maurizio Ferrari
Sfogliando l'opera del lessicografo di Castello di Cireglio si incontrano tanti modi di dire fondati sulla quotidianità spicciola e contadina. Lo spazio alla dissacrazione bonaria, le parolacce addolcite, i tipi umani, i verbi intraducibili e quelli molto espressivi

Prima del chewing-gum c'erano le chicche
di Maurizio Ferrari
Le castagne secche erano le chicche di un tempo e sostituivano le caramelle nel caso in cui non fosse possibile comprarle. Ogni castagna si ammorbidiva lentamente in bocca rilasciando l'aroma delle selvi prima di essere masticata e si mandata giù. Poi la cingomma proveniente dall'America ha cambiato tutte le vecchie abitudini

La Libertà: pensare, esprimersi ed agire senza restrizioni
di Paolo Baldassarri
Breve riflessione sul concetto: una leva che scatta dentro di noi, un moto interiore. Da Jung, che sosteneva meglio essere legati da catene visibili che da catene invisibili, a Leonardo da Vinci che nel suo “Calderugio” descrive il cardellino che avvelena i figli in gabbia: “Meglio morti che perdere la libertà”

Fare all'Amore: così dicevano i nostri nonni
di Maurizio Ferrari
L'espressione è rimasta in uso anche oggi ma ha acquisito un significato diverso, diventando sinonimo di fare sesso. E perdendo così il travaglio interiore, il trasporto spirituale per qualcuno, dunque la parte più poetica e fascinosa. Alla quale faceva seguito, ma solo dopo, anche quella carnale

Quella castagna sola dentro il proprio cardo chiamata "frate"
di Maurizio Ferrari
La parola frate ha assunto un significato curioso, legato all'esperienza quotidiana dei montanini di un tempo. La castagna singola nel cardo è stata associata alla figura solitaria del frate accattone che bussava alla porta delle case. Un esempio di fantasia creativa mista ad ironia, che non è mai venuta meno ai ceti popolari

MONTANINO O MONTANARO? Chiamiamoci come vogliamo, ma uniti dai medesimi valori
di Maurizio Ferrari
Soprattutto chi abita in Alta Montagna è più propenso ad utilizzare il secondo termine. Ma “montanino” veniva usato già da noti letterati nel 1800. Su tutti Policaro Petrocchi da Castello di Cireglio che considerava l'appellativo montanaro “un po' spregiativo e di commiserazione”
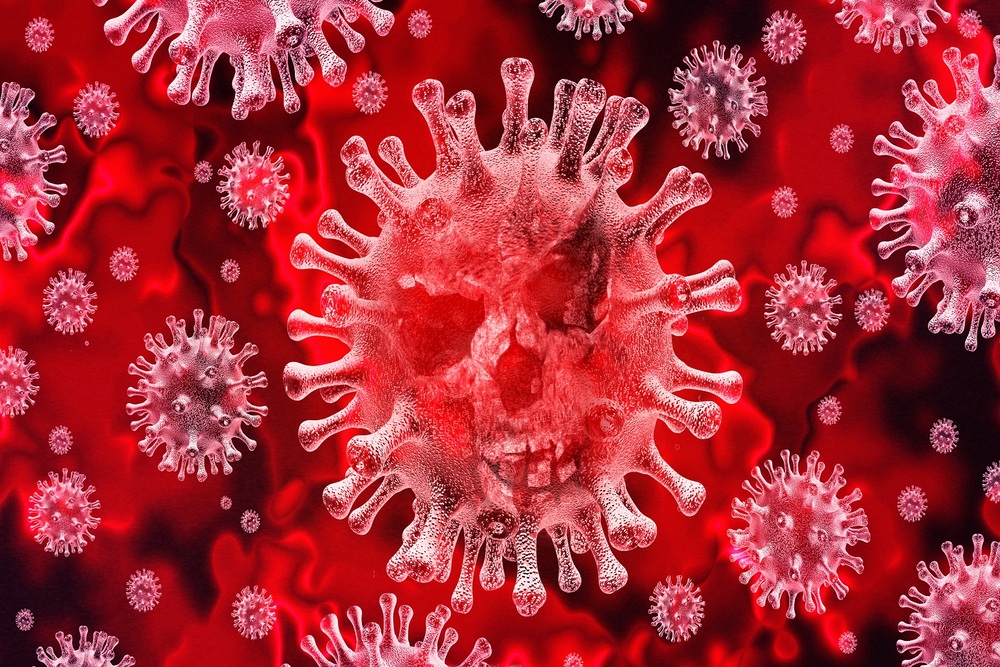
Virus e influenza: due parole che fanno paura (soprattutto in questi giorni)
di Maurizio Ferrari
La prima ha in realtà un'origine rassicurante, quella del “succo”, “l'umore” delle piante. In seguito ha indicato il “veleno” prodotto dagli animali e solo nel 1500 il pus corrosivo di certe piaghe infette. Anche la seconda ha un'origine innocua, riferita allo scorrere dei fiumi e dei torrenti. Fu l'astrologia medievale a caricarla di significati negativi

Quel fungo è una ballerina che si muove al ritmo di danza
di Maurizio Ferrari
In Giappone viene chiamato “fungo danzante” (Maitake). E' il Polyporus frondosus sulla nostra montana detto Barbagino o Fungagnino. In altre regioni conosciuto con il nome di Grifola, Leprina, Fungo imperiale e in molti altri modi. E' più buono e assai più delicato del porcino oltre ad essere dotato di moltissime proprietà officinali

